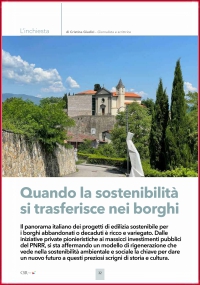Il panorama italiano dei progetti di edilizia sostenibile per i borghi abbandonati o decaduti è ricco e variegato. Dalle iniziative private pionieristiche ai massicci investimenti pubblici del PNRR, si sta affermando un modello di rigenerazione che vede nella sostenibilità ambientale e sociale la chiave per dare un nuovo futuro a questi preziosi scrigni di storia e cultura.
 Leggi l’inchiesta di Cristina Giudici qui sotto, oppure da CSRoggi Magazine – n.4 – Anno 10 – Settembre/Ottobre 2025; pag. 32)
Leggi l’inchiesta di Cristina Giudici qui sotto, oppure da CSRoggi Magazine – n.4 – Anno 10 – Settembre/Ottobre 2025; pag. 32)
Cristina Giudici – Giornalista e scrittirice
Paesi diroccati o in declino che si trasformano in piccole comunità e diventano musei e teatri a cielo aperto, borghi storici abbandonati che rinascono, diventano mete di vacanze ecosostenibili, si trasformano in alberghi diffusi, comunità artigianali, residenze artistiche, strutture polifunzionali.
Comuni riqualificati nelle aree interne e talvolta più depresse del Paese che scoprono un nuovo Rinascimento e diventano attrattivi per il turismo e per chi vuole tornare a vivere nei luoghi di origine. Talvolta ricostruiti rispettando o recuperando l’identità e la memoria dei luoghi, grazie all’intervento di mecenati, l’operosità di famiglie che acquistano ruderi costruiscono le case con le proprie mani, mattone dopo mattone, secondo i principi della sostenibilità ambientale, sociale e persino filosofica.
Una rivoluzione gentile anche grazie al PNRR
Si tratta di una rivoluzione gentile quella in atto da diversi anni che sta cercando di riscoprire nuovi modelli di vita che attirano le nuove generazioni, determinate a sperimentare, lontano dai centri urbani, dove sia possibile coniugare le nuove tecnologie alle tradizioni con un basso impatto ambientale.
Grazie anche agli investimenti del PNRR (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che hanno destinato per i borghi ingenti investimenti (su cui c’è stato ampio dibattito): 380 milioni di euro alla rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici presentate dai Comuni e 420 milioni di euro per 21 progetti pilota di ogni Regione e Provincia autonoma per borghi a rischio abbandono o abbandonati.
I progetti dovranno prevedere l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, come ad esempio scuole o accademia di arti e dei mestieri della cultura, alberghi diffusi, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali (RSA) e imprese creative del triade in Italy dove sviluppare anche progetti culturali, residenze per famiglie con lavoratori in smart working e nomadi digitali.
Una tendenza avviata in molti casi gradualmente nello scorso decennio e ora sempre più consistente, soprattutto dopo la pandemia, perché si tratta di una scelta o di una sfida per chi cerca un’esistenza diversa da quella urbana, spesso diventata insostenibile da un punto di vista economico, oltre che ambientale ed esistenziale. Con un fattore comune: il desiderio di ricreare comunità laddove negli anni del boom economico interi Paesi sono stati svuotati dalle migrazioni interne e permettere di restare o di tornare in territori che coprono complessivamente il 60 per cento dell’intera superficie del territorio nazionale e il 52% dei Comuni, ma dove vive solo il 22% della popolazione. Infatti aumentano anche i Comuni che indicono bandi per giovani under 35 e offrono incentivi per vite ecosostenibili che permettano di tener in vita paesi destinati a morire.
CSRoggi ha fatto un’indagine per scoprire e raccontare le esperienze più innovative.
Il Rinascimento di Castelnuovo D’Avane
Siamo partiti da un borgo toscano del Comune di Cavriglia, a metà strada fra Firenze e Siena, che ha una storia singolare e racconta una storia di sfruttamento e riscatto, di tragedie e capacità di guardare prima degli altri al futuro. In quella che è considerata la porta del Chianti, c’è un borgo che è stato un’antica miniera di lignite: Castelnuovo d’Avane che, a causa del progressivo scavamento e sfruttamento delle risorse naturali, è stato poi abbandonato.

E, come ci ha spiegato con entusiasmo il sindaco Leonardo Degl’Innocenti che definisce questo pro- getto di rigenerazione un vero e proprio Rinascimento: «Castelnuovo D’Avane diventerà un luogo di rinascita con un polo museale dedicato alla memoria, alla Resistenza, perché qui c’è stata la quarta strage nazista in Italia, e un museo dedicato alla trasformazione della materia. Torneranno abitabili le case che una volta erano la dimora dei minatori, ci potranno venire i nomadi digitali, ci sarà un cohousing, una via ciclopedonale, senza barriere architettoniche».
Aggrappato a uno sperone roccioso che si rivolge ad est verso il Valdarno e a Ovest alle colline del Chianti, il borgo si trova in posizione strategica rispetto alle principali direttrici della viabilità autostradale e ferroviaria. Qui nel 1905 nacque la Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno che oltre a dare l’avvio a un’escavazione sistematica del bacino lignitifero costruì la prima Centrale Termoelettrica alimentata a lignite. L’escavazione a cielo aperto, iniziata alla fine degli anni ’50, portò una grossa modifica del territorio. Molti dei paesi che si trovavano sui primi monti del Chianti sono stati distrutti, le loro comunità hanno dovuto ricreare i paesi più a monte, dove non era presente la lignite. Il vecchio borgo è stato infatti progressivamente abbandonato dai suoi abitanti a partire dal 1963 a causa delle escavazioni che avevano compromesso la stabilità del promontorio.
«Castelnuovo D’Avane è stato comprato dal Comune nel 2003 per diventare il borgo dei borghi in Toscana: l’unico selezionato dalla Regione Toscana all’interno del bando del PNRR con un investimento di 20 milioni di euro», aggiunge il sindaco. Il progetto verrà seguito dall’archistar Marco Cosamonti che ha dichiarato: «L’Italia è piena di borghi abbandonati e sono luoghi straordinari e risorse de nostro paese. Noi abbiamo il dovere etico e morale di preservarli e di rigenerarli».

Nella presentazione del progetto, si legge infatti: “La storia di Castelnuovo d’Avane è indissolubilmente legata a un modello di sviluppo che per secoli ha visto lo sfruttamento della terra e delle sue risorse come opportunità economica per la comunità, ma che ha prodotto grandi modi-fiche al paesaggio e, con il tempo, portato all’abbandono del borgo. Oggi il territorio mostra i segni di tutto ciò, come la presenza di laghi artificiali nati dagli scavi minerari della Centrale Santa Barbara di Enel con le sue ciminiere imponenti. Il progetto pone la creatività e l’innovazione a base culturale come fulcro di un processo virtuoso di rigenerazione, per ripopolare il borgo con una nuova energia sostenibile: l’energia culturale”.
E il sindaco ci fa notare che la rinascita di borgo è destinata a dare un messaggio forte alle nuove generazioni che qui vogliono tornare o restare. Un luogo dedicato anche alla memoria perché qui fra il 4 e IT1 luglio 1944 ci fu una strage nazista che uccise 191 civili nelle diverse frazioni del Comune di Cavriglia. Inoltre, grazie alla convenzione del Comune di Cavriglia con Enel che ha avviato una bonifica ambientale fino alle pendici del borgo, verrà realizzato il tratto pedonale che attraversa l’attuale ex area mineraria fino al futuro Parco dello Sport. Il risultato futuro sarà una lunga pista ciclopedonale che collegherà l’Arno fino al Chianti, insomma Castelnuovo D’Avane diventerà presto un simbolo di riscatto del territorio, della sua comunità e della sostenibilità a 360 gradi che sta avvenendo in tanti luoghi d’Italia.
E infatti non è un caso che proprio nel Comune di Cavriglia sia stato girato II film più noto di Alessandro Benvenuti, Ivo il tardivo, che, ambientato nel borgo disabitato di Castelnuovo D’Avane, racconta la storia di Ilvo, un quarantenne con problemi mentali che vive in un Paese abbandonato da lui stesso decorato con l’enigmistica. Chissà se sia stato proprio quello il punto di partenza per il riscatto del borgo.
Ostana: meta internazionale ai piedi del Monviso
Ostana si affaccia sul Monviso. Un secolo fa c’erano 500 case a 1.282 meri d’altezza e 1.220 persone. Negli anni Novanta del secolo scorso eran rimaste solo cinque persone, poi gradualmente il ritorno, «puntando sul recupero delle case, in pietra e legno, e sulla cultura», ci ha spiegato il sindaco Giacomo Lombardo. Risultato: ora ci sono 50 residenti e 500 d’estate, un museo, un coworking per i nomadi digitali. C’è chi ha creato orti e chi alleva capre e crea manufatti di cashmere. Ostana ha creato anche un premio internazionale per lingue minoritarie: con autori di lingua yoruba, inuit, shuar, maori.

(foto: SIlvia Pasquetto)
Un borgo che incarna la resilienza montana, punta sull’identità storica, l’architettura alpina, la lingua occitana, aprendosi alla contemporaneità e alle nuove generazioni. Questo piccolo Comune è stato incluso nell’elenco dei Borghi più Belli d’Italia, un riconoscimento assegnato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANO) per il suo patrimonio architettonico, paesaggistico e culturale unico. Situato in Valle Po, in provincia di Cuneo, questo borgo occitano è noto per la sua rigenerazione, il suo approccio al turismo sostenibile e le sue spettacolari vedute sul gruppo del Monviso. Oggi ha 50 abitanti che attrae anche tanti turisti stranieri e ha anche un albergo costruito su un albero che si chiama Monviso Tree House.
Il vento fa il suo giro è un film di culto del 2005, diretto da Giorgio Diritti, basato su una storia realmente capitata a Ostana e osservata dallo sceneggiatore Fredo Valla. Il titolo riprende un proverbio occitano che dice “tutto ritorna”. Il film non ha un lieto fine e oggi, invece, è diventato un Comune modello, premiato per tutto quello che è stato recuperato, inventato, rigenerato e ha pure un museo etnografico costruito con gli oggetti, lasciti dei residenti perché, come ci ha spiegato il sindaco si è puntato sulla bellezza e ‘identità.
«Qui possono venire tutti ma non si costruisce più nulla dal 1985, e bisogna avere un lavoro. Purtroppo abbiamo un nemico che è la burocrazia: ogni anno dobbiamo pagare 800mila euro di tasse». E così un popolo di rigattieri occitani, obbligati a emigrare, oggi è diventato un simbolo di quello che può diventare una comunità testarda e orgogliosa della propria sostenibilità. «Dopo la diaspora degli anni Sessanta e Settanta, il paese è morto. Poi c’è stato un ritorno graduale e oggi l’età media degli abitanti è di 37 anni. Una comunità autoctona attenta alla solidarietà, all’ambiente, che sta progettando anche un percorso per disabili, una panoramica per vedere tutte le creste del Monviso, e ha anche ospitato il Campo internazionale di volontariato di Legambiente, organizzato in collaborazione con l’associazione locale Bouligar con ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo: Canada, Russia, Taiwan, Serbia, Spagna, Repubblica Ceca e mezza Italia.

(foto: SIlvia Pasquetto)
Una storia straordinaria che dimostra come un luogo abbandonato possa diventare una meta internazionale forse perché la montagna è come la vita che toglie e poi sa restituire. Il sindaco Giacomo Lombardo è tornato in paese nel 1985, portandosi dietro moglie e figli. «Non aveva avuto danni urbanistici, così abbiamo potuto recuperare le abitazioni di pietra e legno, con una ristrutturazione coerente con il paesaggio», conclude il sindaco.
Un’altra leva di azione per farlo rinascere è stata la valorizzazione della cultura e lingua occitana. E oltre ad aver ispirato il film di culto Il Vento fa il suo giro, la storia di Ostana è stata protagonista di un beffardo cortometraggio di Stefano Scarafia, Paolo Casalis e Pino Pace, Il Passo dell’Elefante con cui vinse nel 2012 il Festival Documenteur FilmFest dedicato al falso documentario, mockumentary, inventandosi il ritrovamento di una zanna d’elefante nelle Alpi piemontesi, appartenuta a uno degli elefanti del generale cartaginese Annibale.
Aliano: la rigenerazione che passa dalla cultura
«Spalancai una porta-finestra, mi affacciai a un balcone, dalla pericolante ringhiera settecentesca di ferro e, venendo dall’ombra dell’interno, rimasi quasi accecato dall’improvviso biancore abbagliante», scrisse Carlo Levi nel piccolo borgo dove fu confinato e che ispirò il suo capolavoro Cristo si è fermato ad Eboli.Oggi questo borgo di 860 anime, famoso anche per il Festival “La Luna e i Calanchi” che ogni estate attira migliaia di turisti è al centro di un progetto di riqualificazione: Il Teatro del Tempo.
«Rappresenta un vero e proprio piano di rigenerazione socioculturale finanziato dalla Regione Basilicata nel quadro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e pone il borgo lucano al centro di un progetto per la creazione di un ecosistema creativo fondato su residenze artistiche, laboratori, spazi produttivi, di accoglienza e formativi supportati da nuove dotazioni strumentali, con l’obiettivo di valorizzare una produzione culturale contemporanea capace di attrarre nuove energie e rafforzare la coesione sociale. Una sfida in cui il borgo crede e che sta coinvolgendo tutta la comunità, in collegamento con il sistema territoriale», spiega Francesca Velani, vicepresidente e direttrice Cultura e sostenibilità di Promo PA Fon- dazione che si occupa del coordinamento culturale del progetto di Aliano e di Castelnuovo D’Avane.

Ortofoto Panevino
Perché la bellezza si accompagna alla sostenibilità. E infatti Aliano si è candidata a Capitale italiana della Cultura 2027, inserendosi in una più ampia strategia regionale per la valorizzazione delle aree interne e la rigenerazione dei borghi attraverso la cultura, perché le aree interne, spesso colpite da spopolamento e marginalizzazione, possono diventare protagoniste di un modello di sviluppo più sostenibile.
Questi territori sono strategici per la tutela delle risorse naturali, la transizione energetica, il rafforzamento delle filiere produttive locali e la riduzione della pressione sulle aree urbane congestionate. Spiega Francesco Scardaccione, l’architetto che cura il progetto Teatro del Tempo: «Questo è un borgo di 780 anime che devono accogliere 23mila turisti nella stagione estiva, perciò bisogna ampliare le strutture ricettive senza snaturare la magia del luogo. Perciò bisognaideare rigenerazioni che sposino la filosofia sostenibile con strutture piccole e funzionali, grazie anche all’uso delle nuove tecnologie. Anche se il termine più appropriato sarebbe quello di ricucire, più che rigenerare, perché bisogna ripensarlo inserendosi nelle strutture già esistenti con molta delicatezza. E lo faremo ricorrendo a strutture essenziali, eliminando dove è possibile le barriere archi- tettoniche.
Tutti gli interventi ad Aliano, che dovrebbero terminare nel 2027, affrontano il tema cruciale di valorizzare territori extraurbani senza più immaginare o progettare megastrutture destinate a diventare cattedrali nel deserto, senza impatto ambientale, che aumentino il senso di comunità e diminuiscano la dispersione del territorio. Aliano deve poter essere la terra dell’altrove dove non abbiamo più bisogno di far rumore per rigenerare o meglio ricucire».
Arroccato su un costone di argilla, nel cuore dei Calanchi lucani, concentrato di anfratti, pinnacoli argillosi e panorami dagli ampi orizzonti. Aliano è un cantiere aperto anche per la produzione culturale. Infatti è famoso per il festival “La Luna dei Calanchi”, ideato e diretto dallo scrittore paseologo Franco Ermini. L’architetto Scardaccione ci ha raccontato come ha sviluppato diversi interventi ispirati alla filosofia sostenibile di coniugare nuove tecnologie con il recupero delle tradizioni e affidarsi a strutture minimaliste perché per generare il futuro bisogna eliminare tutto ciò che è superfluo.
Del resto Aliano è uno dei borghi della Basilicata più attivi culturalmente: 10 musei (uno ogni 100 abitanti), candidato a Capitale italiana della Cultura due volte, tra gli 8 finalisti di Capitale Italiana del Libro 2022, Bandiera arancione TCI dal 2018, sede e promotore del Parco Letterario Carlo Levi e di un Carnevale storico italiano riconosciuto dal Ministero della Cultura dal 2018. Aliano vuole diventare un ecosistema professionale per sperimentare, ricercare ed esprimere questa potenzialità, trasformandola in attività e lavoro.
Perché la sostenibilità passa anche dalla cultura. Il borgo diventerà centro di produzione e il centro di produzione prenderà ispirazione dal borgo, dal suo paesaggio, dai suoi abitanti in una dinamica di coinvolgimento attivo e continuo, attraendo persone da fuori e spingendo i residenti, soprattutto i giovani, a considerare il loro paese come un’opportunità, perché durante la pandemia abbiamo compreso cosa fosse possibile creare in maniera dislocata, ma connessa. Il borgo antico ospiterà i laboratori, le residenze, le attività di spettacolo e tutti i professionisti a vario livello coinvolti.
Il Teatro dei Calanchi, grazie a un’opera di manutenzione straordinaria, sarà implementato con alcuni servizi e attrezzature di base per ospitare produzioni che potranno trovare ampia diffusione in luoghi analoghi del bacino Medi- terraneo per creare e poi restituire anche alla comunità in termini di benessere, welfare, acquisizione di competenze, stimolo all’imprenditorialità giovanile, educazione alla sostenibilità ambientale.
Fra gli altri interventi ci sarà anche quello delle “Case oltre il Confino”. Il progetto di restauro archi- tettonico e rifunzionalizzazione de Centro Servizi si propone di trasformare l’edificio in un punto di riferimento funzionale e accogliente a servizio dell’albergo diffuso e del Creative Hub, con particolare attenzione alle esigenze dei turisti e dei cittadini. Le “Case oltre il confino” saranno riprese con operazioni di manutenzione straordinaria atte a renderle maggiormente confortevoli e funzionali, trasformandole in stanze per il nuovo albergo diffuso. Il restauro è inteso come “welfare del paesaggio” e avviene nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) e mediante l’utilizzo di materiali tradizionali e tecniche sostenibili.

Accademia della pasta di Aliano
Oltre al progetto “Teatro del Tempo”, il borgo è oggetto di ulteriori interventi strategici grazie al ricorso a differenti fondi:
- l’Accademia della Pasta Lucana, per recuperare la tradizione della pasta fatta a mano
- l’hub di Telemedicina: l’installazione di un modulo altamente tecnologico “modulo 3×3 m” per la creazione di un presidio, accessibile alla cittadinanza per diagnosi assistite
- il Centro Turistico e Culturale Green: un intervento di edilizia leggera e sostenibile, perfettamente integrato nel paesaggio naturale. Si fonda sull’uso di strutture temporanee e rimovibili, realizzate con materiali ecocompatibili come legno, pietra e tessuti tecnici. La viabilità interna pedonale e ciclabile è disegnata da linee organiche che valorizzano la vegetazione spontanea
- installazioni artistiche: questi interventi rientrano in un più ampio progetto di rigenerazione urbana attraverso l’arte pubblica. Le opere trasformano superfici anonime o deteriorate in poli attrattivi e narrativi, valorizzando il paesaggio urbano e offrendo ai visitatori un’esperienza culturale diffusa, coerente con l’identità lucana e con le strategie di turismo lento e consapevole.
Sagna Rotonda, architettura originale ed efficienza energetica
In Valle Maira, provincia di Cuneo, il borgo di Sagna Rotonda è stato trasformato in una struttura ricettiva diffusa e sostenibile. Il recupero delle antiche baite è avvenuto nel rispetto dell’architettura originale e con un’attenzione particolare all’efficienza energetica. Gli edifici sono stati isolati con materiali naturali e dotati di sistemi di riscaldamento a biomassa. L’energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili e si promuove un turismo a basso impatto ambientale, valorizzando le escursioni e i prodotti a chilometro zero.
È stato riqualificato da una coppia, Giovanni Neyrone e Teresina Piovano. «I ruderi li abbiamo acquistati nel 2008 perché ci è sempre piaciuta la montagna – racconta Giovanni -. L’idea è nata dal connubio di più esperienze personali: a mia nel settore dell’impiantistica e della ristrutturazione come artigiano e quella di mia moglie, nel campo ricettivo turistico, gestendo un Bed & Breakfast. Siamo riusciti a realizzare una struttura completamente autonoma da un punto di vista energetico nel pieno rispetto dell’ambiente, andando ad eliminare qualsiasi emissione di C02 in atmosfera. Oggi viviamo a 1.700 metri di altezza – prosegue Giovanni Neyrone -, in un posto che è isolato d’inverno, perché non c’è la strada asfaltata, e dove d’estate arrivano turisti tedeschi, olandesi, italiani. Con le nostre risorse abbiamo sposato l’ecosostenibilità in tempi non sospetti. Le strutture sono di pietra e legno, l’energia è fotovoltaica, l’illuminazione led.

Sagna Rotonda, sito del Consorzio
Ci sono 30 posti per turisti e siamo inseriti nella rete dei produttori della valle, il consorzio turistico Valle Maira, nato da una rete di un gruppo di piccoli imprenditori che offre 120 attività commerciali, turistiche e artigianali. L’area è stata rivitalizzata e nella stagione estiva ci sono 3mila persone e riusciamo a fare la raccolta differenziata a 1.700 metri d’altezza». Di luoghi così, unici per la bellezza e l’impegno di chi li ha fatti risorgere, ce ne sono tantissimi perché tante persone oggi creano ecosistemi interconnessi che preferiscono fondersi con la natura e andare più piano, costruendo un elogio alla lentezza, ma in realtà vanno veloci verso il futuro.
Santo Stefano di Sessanio, sostenibilità culturale e sociale
Nel documentario La Nostra Pietra si vede un uomo anziano all’interno di una casa restaurata che si commuove e afferma: «Quando sono entrato dentro mi sono messo a piangere, mi è sembrato di vedere mio padre e mia madre. E pietra, è la nostra pietra». Una frase che può essere considerata l’origine e la meta di un lungo e travagliato viaggio fatto dall’imprenditore Daniele Kihlgren per recuperare l’antico borgo medioevale abruzzese di Santo Stefano di Sassanio, oggi diventato l’albergo diffuso di Sexantio. Si trova a 1.250 metri di altitudine, all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.

Un luogo diventato spettrale, come tanti altri sulle montagne appenniniche e che agli anziani abitanti emigrati evocava solo il ricordo della povertà. Daniele Kihlgren lo scopre negli anni ’90 e resta folgorato dalla bellezza e dall’integrità di un luogo abbandonato che recupera in modo filologico, cioè conservativo, dopo aver acquistato una parte del borgo e riuscendo a superare la diffidenza di chi lo aveva rimosso dalla memoria o riteneva la sua sfida impossibile. E lo fa con un approccio che mira a una sostenibilità che è anche culturale e sociale.
Daniele Kihlgren, fondatore di Sextantio, ha scritto: «L’integrità tra territorio e costruito storico si è conservata in alcuni borghi della montagna appenninica non per un’agenda politica ma a causa dello spopolamento, nel più generale e drammatico contesto di impoverimento del Meridione, dell’abbandono della montagna e dell’emigrazione delle sue genti. L’obiettivo di tutela di questo patrimonio storico “minore” e del suo intimo rapporto con il paesaggio è particolarmente importante in quanto questo genere di impianto urbano, diversamente da quello della classicità, “subisce” il territorio, costituendosi storicamente sulle originali curve di livello. Il materiale di costruzione è quello locale e da qui derivano armonie cromatiche di chiara suggestione che confondono ulteriormente il costruito storico con il paesaggio circostante».
Ma queste parole scritte non bastano per spiegare cosa abbia significato far tornare a vivere il borgo storico, recuperando storia, identità, memoria e materiali. Oggi ci vivono oltre 100 persone. Un’impresa difficile e formidabile perché, come dice lui stesso: «Grazie a queste nuove economie, un borgo che già negli anni ’90 del secolo scorso aveva previsto il decennio del suo abbandono all’incirca verso la fine del XXI secolo, destino comune a tanti altri borghi nella montagna appenninica, non ha visto scomparire la popolazione più o meno giovane, con abitanti non più obbligati a una emigrazione lavorativa e che hanno aperto attività in loco e nel contempo, prodotto una discendenza, invertendo dopo generazioni la tendenza di drammatico calo demografico».

Oggi Sextantio Albergo Diffuso, ha riportato in vita un piccolo borgo abruzzese caduto in abbandono, anche grazie al coinvolgimento delle tradizioni locali legate alla produzione dei saponi naturali e alla filatura della lana, tornati oggi fiorenti. Daniele Kihlgren, l’uomo che torna a far vivere i vecchi paesi con tecniche povere e antiche ma capaci di resistere anche ai terremoti e ha investito nel progetto di conservazione del patrimonio culturale rappresentato dalle secolari case di Santo Stefano di Sessa- nio (Aquila), sulle pendici del Gran Sasso, ha preso il Premio Rotondi nel 2009 per il suo metodo di intervento che ha riassunto in un acronimo: RARO, Restauro, Autenticità, Rispetto e Onestà.
| Potremmo scrivere un lungo elenco di recuperi di ambienti guidati dalla filosofia sostenibile in tutto il Paese. Luoghi sconosciuti e meravigliosi. Tutti unici e diversi ma che ci mandano il seguente messaggio: ovunque, anche nei luoghi poveri delle periferie interne del nostro Paese, si sta cercando di portare avanti una rivoluzione gentile per coniugare innovazione e tradizione, identità e difesa dell’ambiente perché l’essere umano si adatta creando ma anche recuperando, vivendo in armonia con la natura, senza deturparla. E mostra soprattutto che la sostenibilità è una necessità filosofica dell’essere umano. Irreversibile. (c.g.J |
(29 settembre 2025)