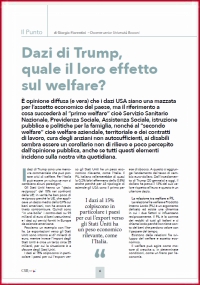È opinione diffusa (e vera) che i dazi USA siano una mazzata per l’assetto economico del paese, ma il riferimento a cosa succederà al “primo welfare” cioè Servizio Sanitario Nazionale, Previdenza Sociale, Assistenza Sociale, istruzione pubblica e politiche per la famiglia, nonché al “secondo welfare” cioè welfare aziendale, territoriale e dei contratti di lavoro, cura degli anziani non autosufficienti, ai disabili sembra essere un corollario non di rilievo e poco percepito dall’opinione pubblica, anche se tutti questi elementi incidono sulla nostra vita quotidiana.
Leggi l’articolo di Giorgio Fiorentini qui sotto, oppure da CSRoggi Magazine – n.4 – Anno 10 – Settembre/Ottobre 2025; pag. 6)
Giorgio Fiorentini – Docente senior, Università Bocconi
 I dazi di Trump sono una manovra commerciale che può portare crisi di welfare. Per l’Italia può essere un vulnus se non si cambiano alcuni paradigmi.
I dazi di Trump sono una manovra commerciale che può portare crisi di welfare. Per l’Italia può essere un vulnus se non si cambiano alcuni paradigmi.
Gli Stati Uniti hanno un “dazio reciproco” del 15% nei confronti della UE; in verità ha ben poco di reciproco perché la UE, che applicava un dazio medio dello 0,9% sui beni americani, non ha ancora attivato contromisure. Quindi sono “in una bolla” i contro-dazi su 93 miliardi di euro di beni statunitensi e i dazi sui servizi forniti in Europa da aziende americane. Facciamo un esempio con l’Italia. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono intorno ai 67 miliardi di euro, mentre invece l’import dagli Stati Uniti è circa un terzo circa 25 miliardi, per cui la situazione è a sfavore degli Stati Uniti.
I dazi al 15% colpiscono in particolare i paesi per cui l’export verso gli Stati Uniti ha un peso economico rilevante, come l’Italia. Il PIL italiano rallenterebbe di quasi lo 0,2% (altri affermano dello 0.5%) anche perché per 43 tipologie di aziende gli USA sono il primo paese di sbocco. A questo si aggiunge l’andamento del tasso di cambio euro-dollaro. Dall’insediamento di Trump (20 gennaio) a oggi, il dollaro ha perso il 13% del suo valore rispetto all’euro e questo è un ulteriore dazio.
La relazione tra welfare e PIL
La relazione fra welfare e Prodotto Interno Lordo (PIL) è un argomento delicato ed esiste una dinamica in cui i due fattori si influenzano reciprocamente. Il PIL è la somma dei redditi di tutti gli italiani e si chiama lordo perché non tiene conto dei beni che perdono valore con il passare del tempo. Esistono delle relazioni fra sviluppo del welfare e assetto economico. Il welfare può agire come motore di crescita o, in determinate condizioni, come un freno per l’economia.
I paesi più ricchi, con un PIL pro capite più elevato, tendono ad avere sistemi di welfare più garantisti, universali e generosi. Questa relazione si basa sulla capacità finanziaria, sulla domanda sociale che con l’aumento della ricchezza genera una richiesta di maggiore protezione sociale e servizi pubblici di qualità, come sanità e istruzione, che diventano diritti “commodity”.
Gli effetti positivi sono l’aumento della produttività e un miglioramento dello status del capitale umano; si stabilizza la domanda interna e si generano per esempio condizioni di conciliazione vita e lavoro e un benessere proattivo per i cittadini. Gli effetti negativi sul PIL sono un eccessivo carico fiscale e qualora si sostengano spese elevate per il welfare è necessario imporre tasse elevate che disincentivano gli investimenti e l’imprenditorialità.
E opinione diffusa (e vera) che questi dazi USA sono una mazzata per l’assetto economico del paese, ma il riferimento a cosa succederà al “primo welfare” cioè Servizio Sanitario Nazionale, Previdenza Sociale, Assistenza Sociale, istruzione pubblica e politiche per la famiglia, nonché al “secondo welfare” cioè welfare aziendale, territoriale e dei contratti di lavoro, cura degli anziani non autosufficienti, ai disabili sembra essere un corollario non di rilievo e poco percepito dall’opinione pubblica anche se tutti questi elementi incidono sulla nostra vita quotidiana. Mettiamo in fila alcune considerazioni.
Un effetto negativo a catena
I “dazi amari” USA incidono sull’export delle nostre imprese (specialmente PMI); i costi per le imprese aumenteranno (con un impatto economico per le imprese italiane che potrebbe aggirarsi tra i 6,7 e i 10 miliardi di euro).
L’impatto comporterà minori entrate fiscali (IRPEF, IRES, IVA) che finanziano la sanità, la previdenza, l’assistenza sociale, l’istruzione; una disoccupazione in aumento con l’esigenza di interventi tramite ammortizzatori sociali; il sistema pensionistico colpito dalla diminuzione dei contributi versati; l’aumento delle povertà e delle disuguaglianze nonché la svalutazione dell’euro e l’inflazione in aumento. E il Made in Italy? In sintesi, un effetto negativo a catena.
Un rimedio potrebbe essere un mercato interno che cresce nonché trovare nuovi mercati tralasciando l’USA («i ventisette paesi UE dovrebbero far leva sulla propria potenza per compensare la perdita di quote di mercato negli Usa con un rafforzamento degli scambi interni all’Unione e nuovi
accordi con Mercosur, Canada, India, Giappone, Brasile», così afferma Tommaso Monacelli della Bocconi). In effetti l’Unione europea ha parlato molto della possibilità di compensare i dazi americani stringendo nuovi accordi commerciali con altri paesi o regioni che, al momento, ancora non si vedono perché i negoziati sono complessi e richiedono tempo.
Inoltre gli esportatori di tutti i paesi colpiti dai dazi cercano nuovi sbocchi per compensare le perdite subite sul mercato americano. Questo fenomeno è noto come deviazione del commercio (trade diversion).
Si dovrebbe innescare un processo di maggiore produttività e aumentare il potere d’acquisto delle famiglie; però questi rimedi si innestano su un contesto ove l’Ocse ci ricorda che l’Italia detiene il primato degli stipendi più bassi tra le economie avanzate. Le ricette sono ormai tutto e il contrario di tutto.
Il vecchio e compensativo non profit
Il welfare è dimenticato (o quasi) anche perché non si è capito quanto “i dazi amari” incideranno su di esso per il fatto che tutte le sue componenti sono le più permeabili e sensibili e già ora sono in sofferenza. Lo Stato è in affanno e cerca di “riparare” il tetto del welfare che ha delle infiltrazioni. Con i dazi si creeranno ulteriori buchi.
Per ovviare, almeno in parte, a questa situazione si dovrà ricorrere ancora al vecchio e compensativo non profit, al volontariato e alle imprese sociali, cioè alle organizzazioni socialmente responsabili profit (si veda anche il welfare aziendale); cioè alla sussidiarietà agita che offre soluzioni e innovazioni di intervento e di servizio. Alcune componenti del welfare sono presidiate in forma rilevante dalle imprese sociali non profit e profit. A livello nazionale il non profit dà un contributo di valore della produzione che ha raggiunto nel 2022 gli 84 miliardi di euro (+5% rispetto al 2020).
Con circa 34.755 enti (circa il 9,5% del totale del non profit) e con circa 450.806 persone retribuite, esso include servizi per anziani, disabili, minori, persone in difficoltà economica, rifugiati, ecc., oltre alle attività di protezione civile (es. interventi in caso di calamità naturali). In sanità ci sono circa 186mila persone (retribuite) che offrono servizi sanitari includendo associazioni di malati, enti che gestiscono servizi sanitari integrativi, case di cura, hospice, servizi di pronto soccorso e trasporto sanitario (es. ambulanze di volontariato), centri di riabilitazione.
E poi il volontariato con circa 700mila cittadini che offrono servizi nel comparto sanitario e assistenziale di cui circa 60mila operano nei servizi ospedalieri e circa 12.500 offrono attività nella lungodegenza. A Milano un pezzo di welfare è gestito da circa 160mila volontari. Le imprese profit “no CSR oriented” saranno tentate (per far fede anche al meccanismo del “dovere fiduciario”) di mantenere i livelli di redditività precedenti e avere il “solito” profitto.
Un effetto “boomerang” nel welfare
Per fare questo, molte imprese “no CSR oriented” attiveranno il taglio dei costi fissi qualificati con minore qualità e minore sostenibilità. Minore occupazione, politiche retributive al ribasso, come abbiamo già detto, creerebbero maggiori bisogni di welfare e ripercussioni economico sociali. Cioè, un effetto “boomerang” nel welfare.
Solo la scelta di un nuovo paradigma di impresa (cioè tutte le imprese devono essere sociali) potrebbe evitare questi minus, a patto che si colga la formula dell’impresa sociale con purpose equilibrato in termini economico-sociali, un’intenzionalità a considerare l’aspetto sociale interno ed esterno come risorsa di vantaggio competitivo, con un’addizionalità verso l‘asset del capitale sociale dei territori-comunità, con un ruolo sussidiario nei confronti dello stato in affanno e con un profitto qualificato da investimenti di responsabilità e sostenibilità. In sintesi imprese che giocano un ruolo sociale non in logica di “bontà loro”, ma come formula di imprenditorialità.
Inoltre dobbiamo cambiare paradigma e sviluppare un welfare dinamico e sostenibile, “un welfare universalistico a protezione variabile” e d’impatto.
Alcuni dati: nel mondo ci sono circa 7 miliardi di abitanti e di essi fruiscono di una forma di welfare sviluppata o mediamente sviluppata circa un miliardo e duecentomila persone; Africa, Asia, America Latina sono prevalentemente a livello di sussistenza minimale di cibo, abitazione, cure sanitarie. Tre miliardi e mezzo di popolazione vive con 2 $, massimo 3, al giorno.
Meno di 500 milioni di abitanti hanno una copertura di welfare significativa e “doc” (una parte dei 27 paesi europei e una parte dei 330 milioni di americani ricordando che questi ultimi, comunque, hanno deficit di pensionamento e una sanità solo “a pagamento privato”.
Le risorse necessarie mancano sempre più
Purtroppo il welfare di Otto von Bismark e di William Beveridge è superato per la mancanza di risorse necessarie (economico finanziarie, strutturali, di contesto lavorativo, demografico) e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, con coraggio, qualche giorno fa ha detto una frase dirompente che probabilmente gli farà pagare un po’ di consenso, ma che è la realtà che tutti sanno: «Lo Stato sociale che abbiamo oggi non può più essere finanziato con ciò che produciamo solo in economia».
Secondo l’OCSE – così si specifica in un articolo di spalla del columnist del Corriere della Sera, Danilo Taino – nei paesi industrializzati nel 1960 le spese per lo stato sociale erano il 10% del PIL, oggi queste sono praticamente triplicate: sono al 30% in Francia e in Italia e al 26.7% in Germania. Per questo le tasse si innalzano in un contesto a economia che non cresce. La coperta è corta e se poi le spese per gli armamenti dovessero erodere la spesa sociale sarebbe un disastro.
Oggi il welfare è in cambiamento perché al ruolo assistenziale, previdenziale, di protezione e di sicurezza sociale si deve aggiungere il dinamismo operativo e la componente imprenditoriale di welfare per un ruolo di sviluppo ed espansivo. Si pensi al welfare aziendale che le imprese considerano elemento incentivante e concorrenziale per l’impresa.
Pensioni, sanità pubblica, sussidi, fiscalità generale e contributi previdenziali, universalismo e categorialità sono i contenuti di un welfare statico e tradizionale (indispensabile) che deve evolversi in un welfare dinamico sulla base della risposta a bisogni specifici di persone e famiglie (welfare “calligrafico”), coinvolgendo la filiera delle imprese-aziende pubbliche e private, profit e non profit.
Un welfare a impatto che si dinamizza nel cambiamento da A a B dove B >A in modo intenzionale e nella convinzione pragmatica che il Welfare incrementa la ricchezza in termini economico-finanziari in un processo a breve-medio-lungo periodo. Le ricerche lo attestano e lo dimostrano. Conciliando vita e lavoro, con un benessere di salute che permette azioni di sviluppo e una motivazione competitiva per i dipendenti delle imprese.
L’esigenza di un welfare allargato e di precisione
Fermo restando che tutti i cittadini hanno diritto a essere protetti da situazioni di dipendenza o di criticità di lungo periodo (malattia, disoccupazione, maternità) e che attengono ai principi del “welfare state”, oggi si è aggiunta l’esigenza di mantenere un livello equilibrato di fruizione di servizi di un “welfare allargato e di precisione”.
Esso è, in modo generativo e trasformativo, utile per lo sviluppo dinamico e accelerato del sistema socio-economico. E le risorse? E necessario un “welfare universalistico a protezione variabile (WUPV)” che per sua natura è integrato e distico (pubblico e privato).
Il WUPV è l’offerta di servizi – socio-assistenziali, socio-sanitari, culturali, di entertainment, sportivi e così via – per tutti i cittadini che però devono integrare i costi di questa opzione. Pagare tariffe a copertura di alcuni costi e pagare un prezzo per il welfare discrezionale.
Molte organizzazioni (imprese sociali profit e non profit) che erogano servizi del “welfare allargato e di precisione” e di “secondo welfare” hanno una formula di gestione a costi contenuti. “Con profitti garbati” direbbe l’imprenditore di successo e di EBITDA alto, Brunello Cucinelli.
È proponibile e necessario entrare in una logica di WUPV; cioè non esiste più la possibilità di avere un welfare universalistico assoluto, senza compartecipazione finanziaria (famiglie, singoli, imprese ecc.), che possa dare risposta da parte dello Stato e dalle strutture private delegate per tutto il set dei bisogni-domanda del sistema. Ovviamente sussidiando le famiglie e le persone che non hanno reddito sufficiente per far fronte ai costi di alcuni dei servizi di welfare.
Tutti gli stati industrializzati promettono provvedimenti che estendono la rete dei servizi di welfare, istituiscono prelievi fiscali fortemente progressivi, intervengono a sostegno dell’occupazione o del reddito dei disoccupati, sviluppano politiche sociali e di sostegno economico per gli immigrati che si ispirano all’universalismo assoluto come principio di fondo, ma non riescono a gestire la sostenibilità economico finanziaria complessiva. I dazi hanno aggravato la situazione.
(29 settembre 2025)