Per troppo tempo l’energia dello sport è rimasta distante dall’equilibrio del pianeta terra. Oggi invece sta emergendo una nuova consapevolezza dettata dalla necessità di proteggere l’ambiente in tutte discipline atletiche e iniziare una rivoluzione verde che talvolta avvia processi di economia circolare.
(leggi l’inchiesta di Cristina Giudici qui sotto, oppure da CSRoggi Magazine – n.2 – Anno 10 – Aprile/Maggio 2025; pag. 52)
Cristina Giudici – Giornalista e scrittrice
Sono numerosi gli atleti che anche in Italia hanno sentito il fischio d’inizio della nuova partita: la sfida urgente per lo sport sostenibile che sta trasformando la pratica sportiva, negli stadi, sulle onde del mare, in sella a una bicicletta, nelle strade dei runner che corrono e raccolgono rifiuti grazie alla diffusione ormai capillare del “plogging” e sulla neve, dove fioccano le petizioni per un’attenzione maggiore all’impatto ambientale.
Per troppo tempo l’energia dello sport è rimasta distante dall’equilibrio del pianeta terra. Oggi invece sta emergendo una nuova consapevolezza dettata dalla necessità di proteggere l’ambiente in tutte discipline atletiche e avviare una rivoluzione verde che talvolta avvia processi di economia circolare.
Nell’agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sono stati fissati diversi obiettivi per rendere lo sport un motore di cambiamento. Obiettivi che poi vanno tradotti in pratica tramite la realizzazione di eco-stadi plastic free, con pannelli fotovoltaici, riciclo di materiale sportivo, divise ecosostenibili, smaltimento dei rifiuti differenziato, riduzione degli sprechi e creazione di eco-sistemi che siano integrati con la comunità a cui dare servizi. Ma in tutti gli sport la sostenibilità è diventata un’allarmante priorità. Infatti si moltiplicano gli appelli e le iniziative personali di atleti impegnati nella salvaguardia del pianeta semplicemente perché se non c’è un pianeta (sano) in futuro non ci potrà essere alcuna partita.
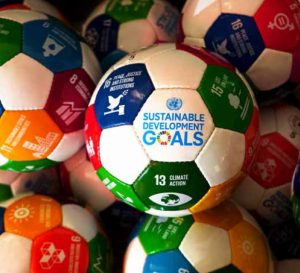 Gli obiettivi sostenibili del mondo del pallone
Gli obiettivi sostenibili del mondo del pallone
Secondo la Figc, la Federazione Italiana Gioco Calcio, il calcio italiano, considerando anche l’indotto, ha un ‘incidenza sul PIL di 11,3 miliardi di euro. Perciò la Carta sulla sostenibilità ambientale del calcio elaborata nel 2022 ha costituito un passo importante perché ha fornito le linee guida a tutti i club (anche dilettantistici) affinché stadi e centri sportivi siano progettati o riconvertiti nel rispetto dell’ambiente mediante l’utilizzo di materiali sostenibili, efficienti dal punto di vista dei consumi energetici e delle risorse naturali, integrati nel contesto urbano e territoriale.
Nel documento si afferma che “Le Federazioni europee e gli attori della famiglia del calcio come le leghe e altre associazioni, anche su stimolo dell’Uefa, sono sempre più consapevoli della necessità di adottare azioni volte a coinvolgere un numero ampio di stakeholders al fine di intraprendere iniziative indirizzate a ridurre l’impatto ambientale dell’attività calcistica”.
L’Uefa lo ha affermato con chiarezza: “Il nostro obiettivo è sbloccare il potenziale dello sport per promuovere cambiamenti positivi per la società e l’ambiente”. Nonostante i progressi, la strada verso un calcio italiano completamente sostenibile è ancora lunga. Le sfide burocratiche per la realizzazione di nuovi impianti e la necessità di investimenti significativi rappresentano grandi ostacoli da superare. Infatti si stima che solo il 10% degli stadi abbia avviato processi mirati alla eco-sostenibilità. Tuttavia l’impegno di alcune società pioniere e la potenziale spinta da parte delle nuove generazioni di tifosi e giocatori fanno sperare in un futuro in cui il calcio italiano sarà non solo un’eccellenza sportiva, ma anche un modello di responsabilità ambientale.
Gli eco-stadi
Lo Stade de Suisse a Berna è stato tra i primi nel mondo ad aver attuato una politica verde, dotandosi di un impianto solare in grado di soddisfare il proprio fabbisogno energetico e quello di 400 abitazioni nelle vicinanze ed è importante ricordare il caso esemplare della Forest Green Rovers, una squadra inglese che ha adottato l’alimentazione vegana, avviando la costruzione del primo stadio interamente realizzato in legno. Si chiama Eco Park Stadium ed è stato progettato dallo studio dell’archistar Zaha Hadid.
In Italia ci sono varie società che hanno adottato politiche ESG (Environmental, Social, and Governance) fra cui il Gewiss Stadium dell’Atalanta e la Juventus che ha programmato una strategia denominata “Black, White & More” delineando sei pilastri chiave: Emissioni in Corner, Assist alla Circolarità, People First, Sustainable Glocal Club, Centralità del Tifoso e Sustainable Leadership.

Udinese: l’eco-stadio Blueneregy Stadium
Il caso più virtuoso, capace di coniugare sostenibilità sportiva e progetti sociali sul territorio è quello del club dell’Udinese che nell’aprile scorso ha completato il parco solare dello stadio Dacia Arena che ora si chiama Blueneregy Stadium. Un esempio straordinario di quello che può fare il calcio per promuovere il cambiamento.
Lo stadio è stato trasformato in un parco solare per volontà della famiglia Pozzo, proprietaria del club friulano. Oltre all’impegno nella riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività, ha realizzato un impianto all’avanguardia che integra soluzioni innovative per il risparmio energetico e la gestione sostenibile delle risorse destinate al territorio e a progetti sociali che puntano a creare un circuito di economia circolare per l’intera comunità. Spiega Piera Abramo, Social and environmental sustainability officer del club friulano: «Il parco solare è stato realizzato grazie alla partnership con Bluenergy e ha adottato un diverso approccio culturale che coinvolge anche i tifosi e il territorio. Energia rinnovabile, isole ecologiche, il nostro eco-stadio è accogliente per le famiglie anche nelle curve dei tifosi».
La comunità energetica dell’Udinese
“Energia in campo” è infatti la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) calcistica che permetterà ai sostenitori del club e alle aziende che aderiranno al progetto di condividere e utilizzare la parte di energia prodotta dal parco solare del Bluenergy Stadium e non impiegata nella struttura tramite l’impianto fotovoltaico d’avanguardia con 2.409 pannelli solari di ultima generazione in grado di produrre una media di circa 3mila kWh al giorno. Progettato con il supporto del Politecnico di Milano in qualità di energy advisor, l’impianto, i cui pannelli occupano un totale di 4.615 metri quadrati di superfìcie, aggiunge ulteriori elementi di innovazione a una struttura sportiva che rappresenta già oggi un riferimento in Europa per gli stadi del futuro in termini di design, multifunzionalità, sicurezza e sostenibilità.
La struttura sportiva assorbirà circa il 70% dell’energia generata dall’impianto, mentre il restante 30% sarà messo a disposizione della comunità energetica che potrà così godere degli incentivi che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) riconosce per l’energia prodotta dall’impianto e contestualmente consumata dalla CER.
Queste risorse saranno destinate a un progetto benefico di utilità sociale che ha l’obiettivo di supportare l’ASUFC (Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale) e, in particolare, la struttura di Neuropsichiatria Infantile nell’affrontare la problematica relativa ai disturbi del comportamento alimentare nei minori e negli adolescenti.
Oltre alle attività e ai trattamenti dei centri diurni per i disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva è prevista nel corso del 2025 l’attivazione del primo Centro residenziale per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare nella Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie al contributo derivante dall’attività della CER, sarà possibile non solo finanziare l’acquisto di beni e materiali, ma anche sviluppare laboratori e attività anche all’esterno delle strutture, offrendo ai pazienti esperienze riabilitative in un ambiente non esclusivamente ospedaliero, creando un sistema di economia circolare pionieristico per l’Italia.
Il club friulano ha creato un impianto sportivo capofila per il calcio italiano nella sfida per l’azzeramento delle emissioni di CO2 e su altri fronti della salvaguardia ambientale. E non solo. La struttura può essere utilizzata tutti i giorni della settimana perché all’interno si trovano anche Il meeting center, la sede della società, gli uffici di aziende, istituzioni e negozi e in futuro persino un museo, oltre a un wellness center e aree dedicate alle famiglie, diventando una seconda casa per tifosi e cittadini.
Condivisione dell’energia rinnovabile
Bluenergy ha inoltre fornito in questi anni al club energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili per un risparmio di circa 6.500 tonnellate di CO2. Ai risultati sul territorio si affiancano quelli raggiunti a livello internazionale da Udinese Calcio in qualità di membro del Working Group ECA – la Confindustria del calcio europeo – e quale club firmatario del Patto per il clima alla conferenza ONU COP29 di Baku insieme a Liverpool, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, Real Betis, Porto e la squadra azera Qarabag.
«Il completamento del parco solare e l’avvio della prima CER del mondo del calcio segnano un traguardo straordinario nel nostro impegno per la sostenibilità. Questo progetto non solo riduce in modo significativo l’impatto ambientale dello stadio ma introduce un modello innovativo di condivisione dell’energia rinnovabile che coinvolge imprese e tifosi, creando valore per il territorio» ha commentato Alberta Gervasio, Ad di Bluenergy Group. «Un progetto unico che fa il paio con il Solar Park e ci permette di essere un modello globale di sostenibilità» ha commentato Franco Collavino, Direttore generale di Udinese Calcio.
L’esempio dell’Udinese è destinato a fare scuola perché sarà in grado di integrare lo spazio sportivo con la comunità, seguendo i principi dell’economia circolare: il club friulano ha creato una partnership anche con Miomojo per una nuova linea di accessori sportivi realizzati con uno dei materiali Next-Gen più innovativi, derivato dagli scarti dell’industria olearia. Secondo la classificazione basata sui parametri ESG il club bianconero è al quarto posto a livello mondiale.
E restando al mondo del calcio, anche il campionato EURO 2024 è stato il più sostenibile di sempre grazie alla diminuzione del 75% dei trasferimenti delle squadre in aereo mentre la produzione di rifiuti è scesa del 34% e le emissioni di anidride carbonica sono state ridotte del 10%. Morale: il calcio sta gradualmente cambiando approccio anche grazie alla pressione di atleti diventati ambasciatori della rivoluzione verde.

Atleti costruttori di futuro
Sono davvero numerosi gli atleti che competono per la sfida sostenibile. William Troost-Ekong, il giocatore olandese di origini nigeriane che ora gioca nel club saudita Al-Kholood Club, ha invitato tutti a tifare per la stessa squadra: “la salute del pianeta” e nel 2023, quando era in prestito alla Salernitana, ha annunciato di voler rendere i suoi trasferimenti “carbon neutral”, compensando con la piantumazione di alberi tramite Alberami: un progetto che aiuta gli olivicoltori a ripiantare oliveti e adottare pratiche agricole sostenibili.
«Viaggiamo molto per le partite – ha spiegato Troost-Ekong – e piantare alberi è un gesto semplice ma concreto per assorbire la CO2 e contribuire a un futuro più verde». Il progetto ha coinvolto anche i tifosi che hanno potuto partecipare attivamente alla piantumazione. L’ex portiere della Nazionale Italiana Gigi Buffon è stato invece protagonista di un noto spot dell’Unione Europea e Uefa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico. Nello spot “Every Trick Counts” (Ogni trucchetto conta, ndr) lo si vede lanciare dal giardino di una casa un pallone che spegne l’interruttore della luce, abbassa il termostato di tre gradi e chiude la porta del frigo lasciata aperta.
Il grande e pluricampione di Formula 1 Lewis Hamilton è diventato un ambasciatore della rivoluzione verde, ha ridotto le proprie emissioni di carbonio e venduto il suo aereo privato. Fervente sostenitore della lotta contro il cambiamento climatico, ha adottato la dieta vegana, l’utilizzo di auto elettriche e creato il team X44 con il quale ha partecipato per tre anni alla corsa delle auto elettriche Extreme E il cui motto è: “Race for the planet” (corsa per il pianeta, ndr). O ancora: Mathieu Flamini, giocatore nel Milan per diverse stagioni, dopo il ritiro ha co-fondato GF Biochemicals, un’azienda pionieristica nel campo della chimica verde.
Ma la palma d’oro della sostenibilità l’ha vinta il centrocampista del Genoa, il norvegese Morten Thorsby, che ha creato in Italia la fondazione We Play Green per creare una generazione di atleti-influencer green, arrivando a creare la Sustainability League, dove non vince chi mette più palloni in rete ma chi eccelle nella battaglia contro l’impatto ambientale. Soprannominato “La Greta Thunberg del calcio” è famoso perché ha indossato la maglia numero 2 della Sampdoria – quando era giocatore di questa società – per ricordare ai tifosi l’accordo di Parigi sul cambiamento climatico.
Ciclismo: un Giro d’Italia sempre più verde
Il Giro d’Italia ha aumentato l’utilizzo di veicoli elettrici e ibridi per lo staff e le ammiraglie, riducendo le emissioni di gas serra. Si è posta maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti lungo il percorso e nelle aree di arrivo e partenza, con l’obiettivo di massimizzare la raccolta differenziata.
Inoltre, si promuovono attivamente campagne di sensibilizzazione per il pubblico sull’importanza della mobilità sostenibile e del rispetto dell’ambiente, sfruttando la grande visibilità dell’evento. L’obiettivo è di rendere il Giro non solo una competizione sportiva di alto livello, ma anche una piattaforma per promuovere messaggi di sostenibilità.
Sport invernali: l’appello degli sciatori
In attesa delle Olimpiadi invernali del 2026, in Italia diverse località e organizzazioni stanno adottando misure per mitigare il proprio impatto ambientale. Ciò include investimenti in impianti di innevamento artificiale più efficienti dal punto di vista energetico e idrico, la promozione di trasporti pubblici e condivisi per raggiungere le stazioni sciistiche, e la gestione sostenibile delle risorse naturali, come la protezione della biodiversità alpina.

Alcune stazioni stanno anche sperimentando l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per alimentare gli impianti di risalita e le strutture ricettive. La sfida è quella di continuare a praticare gli sport invernali in modo responsabile, preservando la bellezza e la fragilità dell’ambiente montano. Allarmati dal cambiamento climatico, nel febbraio scorso oltre 500 sciatori professionisti hanno scritto una lettera a Johan Eliasch, presidente della Federazione internazionale di sci (Fis), per chiedere di mettere in atto soluzioni per rallentare il processo di scioglimento delle nevi a seguito del cambiamento climatico. Tra i firmatari anche l’italiana Federica Brignone, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.
Del resto la stessa Fis aveva annunciato, nel gennaio del 2024, i punti di una nuova linea d’azione volta a consolidare e implementare la sostenibilità all’interno degli sport invernali.
La diffusione del plogging
Il plogging è un esempio emblematico di come lo sport possa fondersi con l’impegno ambientale in modo attivo e partecipativo. Nato in Svezia, il termine combina le parole svedesi “plocka upp” (raccogliere) e “jogging”.

In sostanza, il plogging consiste nel correre o camminare, raccogliendo i rifiuti che si incontrano lungo il percorso. In Italia, il movimento del plogging sta crescendo rapidamente, creando gruppi e comunità di cittadini che condividono la passione per l’ambiente. Spiega Andrea Amato, presidente di Wau! Milano (acronimo di We Are Urban) e pioniere del plogging nel capoluogo lombardo: «Sette anni fa abbiamo iniziato l’attività di plogging con 4 km di percorso verso Corsico e Buccinasco. Un’attività che poi è esplosa in tutta Italia.
Ora tante associazioni stanno organizzando eventi simili, magari anche solo camminando, per ripulire le strade. Abbiamo avuto anche l’onore di avere il vicecampione del mondo due anni fa, Fabio Gonella. Pensiamo che possa essere utile per il bene della città e il benessere dei cittadini: correre, fermarsi, piegarsi, raccogliere rifiuti, tornare a correre sono azioni che fanno bene al cuore e all’ambiente in cui si vive”.
Ormai sono numerosissimi i gruppi di cittadini che si incontrano per fare plogging e c’è, appunto, persino il campionato mondiale: il World Plogging Championship. L’ultimo si è svolto Il 28 e 29 settembre del 2024 ed è stato sponsorizzato nel 2024 da SEA srl come main sponsor e Fondazione Cariplo come gold sponsor, Vietti, Montello, RICREA, Scarpa e PEFC.
Durante il campionato sono stati assegnati anche dei premi speciali, tra cui il quello per aver raccolto il maggior quantitativo di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche) conferito alla serba Natalija Cacarevic, mentre a Matilde Gerardi è andato il premio per il maggior numero di pile, batterie e accumulatori. Il plogging sta diventando anche una forma di turismo sostenibile e una diversa maniera di creare aggregazione su valori comuni. Un esempio di quanto profondo sia stato il cambiamento culturale e sociale nello sport. Un cambiamento che spinge aziende e istituzioni verso un’economia oltre che eco-sostenibile anche più circolare.
(19 maggio 2025)
(foto: ©shutterstock)

