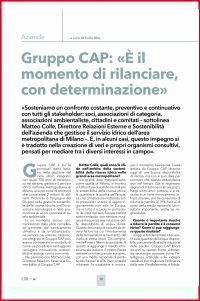«Sosteniamo un confronto costante, preventivo e continuativo con tutti gli stakeholder: soci, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, cittadini e comitati – sottolinea Matteo Colle, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità dell’azienda che gestisce il servizio idrico dell’area metropolitana di Milano -. E, in alcuni casi, questo impegno si è tradotto nella creazione di veri e propri organismi consultivi, pensati per mediare tra i diversi interessi in campo».
Leggi l’articolo a cura di Carlo Rho qui sotto, oppure da CSRoggi Magazine – n.3 – Anno 10 – Giugno/Luglio 2025; pag. 10)
 Gruppo CAP è tra le principali realtà italiane nella gestione del ciclo idrico integrato: con quasi 100 anni di esperienza nel settore, gestisce il servizio idrico nell’area metropolitana di Milano, una porzione di territorio che conta oltre 2 milioni di abitanti. Profondo è l’impegno del Gruppo nella gestione sostenibile delle risorse idriche, nell’innovazione tecnologica e nella promozione di azioni concrete di tutela ambientale.
Gruppo CAP è tra le principali realtà italiane nella gestione del ciclo idrico integrato: con quasi 100 anni di esperienza nel settore, gestisce il servizio idrico nell’area metropolitana di Milano, una porzione di territorio che conta oltre 2 milioni di abitanti. Profondo è l’impegno del Gruppo nella gestione sostenibile delle risorse idriche, nell’innovazione tecnologica e nella promozione di azioni concrete di tutela ambientale.
In un momento storico contraddistinto dalle sfide complesse generate dal cambiamento climatico e da un’urbanizzazione sempre più intensa, l’approccio integrato di Gruppo CAP può essere considerato un modello di come sia possibile e vantaggioso coniugare innovazione, sostenibilità e dialogo con la comunità.
Ne parliamo con Matteo Colle, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di Gruppo CAP.
Dottor Colle, quali sono le sfide nell’ambito della sostenibilità della risorsa idrica nelle grandi aree metropolitane?
«Le grandi aree metropolitane, come quella di Milano, si trovano ad affrontare due sfide centrali per la sostenibilità della risorsa idrica: la quantità e la qualità dell’acqua. La crisi climatica sta mettendo sotto pressione i sistemi di approvvigionamento non solo in Europa, ma in tutto il mondo. In particolare, le città del sud Europa stanno sperimentando con sempre maggiore frequenza una riduzione della disponibilità di acqua dolce. Questo fenomeno è causato da diversi fattori, tra cui l’innalzamento delle temperature e l’aumento del livello di stress idrico. Ciò compromette l’intera filiera idropotabile.
A questo si aggiunge il ritardo infrastrutturale italiano: il nostro Paese detiene un triste primato europeo, con una media nazionale di perdite idriche pari al 41%. Nel contesto milanese, la situazione è ancora, per il momento, favorevole. L’area gestita da Gruppo CAP dispone oggi di una buona disponibilità di risorsa, ma non si può dare per scontato che questa abbondanza duri nel tempo. Già si registrano segnali di riduzione in alcuni pozzi. Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito a un forte rinnovamento infrastrutturale, che ha consentito di ridurre le perdite al 19%, ben al di sotto della media nazionale. Un risultato importante, anche se migliorabile».
Quanto è importante riuscire a ridurre le perdite e il consumo idrico? Come si può raggiungere questo risultato?
«Oggi è fondamentale intervenire sulla quantità dell’acqua disponibile, concentrandosi sulla riduzione delle perdite. Gruppo CAP lavora da anni su questo fronte, adottando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e le indagini satellitari per migliorare l’efficienza della rete. Parallelamente, è fondamentale comprendere l’evoluzione della falda acquifera. Gruppo CAP preleva acqua solo dalla falda profonda, a circa 100 metri. Già da tempo è stato avviato uno studio sui rischi legati al cambiamento climatico, anche attraverso modelli predittivi basati sull’IA, per prendere decisioni gestionali efficaci.

Depuratore di Assago
Ultimo ma non meno importante, è necessario agire sui comportamenti individuali. Gli italiani consumano in media 215 litri di acqua al giorno, ben oltre i 165 litri della media europea. Molta di quest’acqua è potabile, anche quando non sarebbe necessario. È urgente sensibilizzare sull’uso consapevole della risorsa. Ma è anche responsabilità del gestore: oggi l’acqua potabile è l’unica distribuita dalle reti, anche per usi non potabili come, ad esempio, l’innaffiatura o lo scarico del WC. Per questo è importante iniziare a ragionare sulla realizzazione di reti duali, che permettano di utilizzare anche acqua di prima falda o depurata per usi civili non potabili».
Quali sono le principali innovazioni che avete previsto nei prossimi anni per migliorare ulteriormente i vostri processi e servizi?
«Dobbiamo considerare anzitutto che il servizio idrico integrato è caratterizzato, per sua natura, da processi fortemente energivori. In questo senso è fondamentale per chi opera in questo settore pensare a soluzioni per ridurre l’impatto del processo industriale di fornitura, raccolta e trattamento delle acque. Gran parte delle innovazioni portate avanti in questi anni si sono concentrate soprattutto sull’ambito della depurazione delle acque reflue, ovvero quella fase in cui l’acqua viene restituita all’ambiente e quindi ripulita il più possibile da potenziali sostanze inquinanti.
Si parla negli ultimi anni di sistemi quaternari di depurazione, che sono pensati e progettati proprio per eliminare alcuni micro-inquinanti emergenti, come per esempio le microplastiche o alcune tipologie di farmaci. La seconda grande sfida è quella del riuso delle acque depurate: l’acqua proveniente dai nostri depuratori è di ottima qualità e ampiamente compatibile con usi diversi, tra cui l’agricoltura. A oggi nel nostro Paese la percentuale di riuso, a discapito di un grande potenziale, è ancora molto bassa e lontana dai modelli virtuosi di alcune aree del Nord Europa, come i Paesi Bassi, o di Israele. Gruppo CAP a oggi si attesta su una media di 45% di acque riutilizzate in agricoltura: ciononostante, si può fare molto di più e su questo serve un dialogo aperto e molto trasparente con tutta la filiera agricola, dall’agricoltore al consorzio di bonifica, che sono gli interlocutori principali.
Il vostro impegno è particolarmente forte anche in ambito di qualità dell’acqua…

Depuratore di Robecco sul Naviglio (Mi)
«Sì, quella legata alla qualità dell’acqua rappresenta la nostra terza frontiera di innovazione, non certo meno rilevante delle precedenti. Oggi la sicurezza dell’acqua potabile è messa alla prova da due fattori principali che possono comprometterne la qualità. Il primo è legato alla crisi climatica e all’innalzamento delle temperature medie, che determinano un aumento del rischio microbiologico: temperature più elevate creano un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri. È un fenomeno che stiamo già osservando concretamente, con una crescita del rischio di contaminazioni microbiologiche direttamente correlata al riscaldamento globale. Per questo, i gestori si stanno attrezzando per affrontare la questione, sviluppando soluzioni tecnologiche capaci di monitorare in modo sempre più tempestivo e preciso questi parametri, così da garantire ai cittadini i più alti standard di sicurezza. L’altro aspetto critico è quello legato alla chimica.
La crescente complessità delle sostanze presenti nell’ambiente richiede un continuo aggiornamento tecnologico per rendere le analisi dell’acqua potabile sempre più sofisticate. L’obiettivo è quello di riuscire a individuare molecole nuove, oppure tracce anche minime di sostanze potenzialmente nocive, che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute pubblica. Questo approccio non riguarda solo la qualità dell’acqua in sé, ma si inserisce in una strategia più ampia di gestione del rischio lungo tutta la filiera idropotabile di Gruppo CAP. In quest’ottica, l’azienda si è mossa in anticipo rispetto al panorama nazionale, adottando tra le prime in Italia un Piano di Sicurezza dell’Acqua – il cosiddetto Water Safety Plan – basato su un’approfondita analisi del rischio. Questo strumento permette di monitorare un’enorme quantità di variabili, offrendo una garanzia ulteriore sulla qualità dell’acqua distribuita e rafforzando la protezione dei cittadini sotto il profilo sanitario».
Come viene coniugata la sostenibilità in Gruppo CAP? Quali sono gli elementi che contraddistinguono il vostro approccio, soprattutto nelle relazioni con il territorio e con le comunità locali?
«Molto spesso si tende a considerare il servizio idrico come un comparto industriale naturalmente sostenibile. Ma in realtà non è così. Il servizio idrico è infatti come ho accennato prima, un settore fortemente energivoro, tra i più energivori in assoluto in Italia. Questo perché, di fatto, significa spostare l’acqua contro la forza di gravità: prelevarla dal sottosuolo e portarla in superficie richiede un considerevole dispendio energetico. Il sistema si basa essenzialmente su impianti di pompaggio complessi, che comportano consumi di energia molto elevati. A questi si aggiungono i trattamenti necessari per rendere potabile una parte dell’acqua prelevata, che richiedono ulteriori processi tecnici ed energetici.
Senza contare poi i grandi impianti di depurazione, dove l’acqua viene convogliata e ripulita da sostanze inquinanti; anche in questo caso grandi consumi energetici e produzione di rifiuti. L’attenzione si concentra, dunque, da un lato sulla riduzione delle emissioni e dell’impronta carbonica. Ogni anno, durante i processi depurativi, Gruppo CAP emette diverse centinaia di tonnellate di CO2 equivalente, sotto forma di gas climalteranti. Anche in questo caso la chiave di volta è l’innovazione. L’azienda ha scelto infatti già da tempo di integrare pienamente la sostenibilità nella propria strategia industriale, adottando un approccio sistemico. In questo percorso, Gruppo CAP ha aderito alla Science Based Target Initiative, impegnandosi formalmente a ridurre del 42% le proprie emissioni Scope 1 e 2 entro il 2030. Un obiettivo concreto e misurabile, che richiede trasformazioni profonde e azioni mirate».
In relazione alla produzione di rifiuti speciali e all’impatto che la vostra attività produce sull’ambiente, invece, qual è il vostro impegno in questo ambito?
«Il tema dei rifiuti non è secondario. Il processo di depurazione, infatti, si conclude con la restituzione di acqua pulita all’ambiente, ma anche con la produzione di fanghi di depurazione, veri e propri rifiuti speciali. Gruppo CAP ne gestisce oltre 80mila tonnellate ogni anno: si tratta di quantitativi importanti, che devono essere trattati in modo adeguato così da non creare impatti ambientali significativi. Anche su questo fronte, l’impegno dell’azienda è strutturato e si concretizza in processi integrati di economia circolare: ricordo che CAP è stata la prima azienda italiana del servizio idrico a produrre biometano dai fanghi di depurazione. Gruppo CAP è consapevole che ogni impianto industriale ha un impatto sull’ambiente che lo ospita. Lo si è compreso a fondo anche in relazione al tema della biodiversità, su cui l’azienda realizza interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale. Ma esiste anche un impatto di natura sociale, spesso più delicato da affrontare.
Alcuni impianti – come i depuratori – possono generare disagi legati agli odori; altri, come gli impianti di termovalorizzazione, sollevano preoccupazioni sul fronte della qualità dell’aria. Per affrontare in modo trasparente queste problematiche, Gruppo CAP ha scelto da sempre la via del dialogo. Un confronto costante, preventivo e continuativo con tutti gli stakeholder: soci, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, cittadini e comitati. In alcuni casi, questo impegno si è tradotto nella creazione di veri e propri organismi consultivi, pensati per mediare tra i diversi interessi in campo. Un esempio concreto è il Residential Advisory Board della BioPiattaforma di Sesto San Giovanni: uno dei primi modelli in Italia di organo consultivo territoriale che coinvolge direttamente la comunità locale, le aziende e le amministrazioni, creando uno spazio strutturato per la partecipazione, il confronto e la condivisione delle scelte».

BioPiattaforma di Sesto San Giovanni
Parliamo del vostro Bilancio di Sostenibilità. Quali sono le principali novità che si trovano al suo interno?
«La sfida legata al bilancio di sostenibilità di quest’anno è stata particolarmente rilevante, perché per la prima volta Gruppo CAP ha adottato la CSRD, la nuova direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità. Questo passaggio ha comportato un profondo ripensamento del flusso di rendicontazione, ma anche la necessità di rivedere e trasformare alcuni processi aziendali più ampi, con implicazioni che vanno ben oltre la semplice stesura del documento. In particolare, l’introduzione del principio della doppia materialità ha rappresentato uno dei principali elementi di discontinuità: questa logica richiede alle imprese di esaminare la propria attività e la propria catena di valore per comprendere quali impatti generano verso l’esterno.
Ma non solo. La doppia materialità impone anche di considerare i fattori esterni che possono influenzare l’organizzazione, come il cambiamento climatico o le dinamiche sociali, e di valutarne i riflessi economici e finanziari sul business. Si tratta, quindi, di passare da una visione tradizionale inside-out – che guarda dall’interno verso l’esterno – a una prospettiva outside-in, capace di integrare ciò che avviene nel contesto con gli orientamenti strategici aziendali. È un approccio potente perché non si limita a mappare rischi e opportunità, ma richiede anche di definire le politiche di gestione degli impatti e di individuare obiettivi chiari accompagnati da indicatori di performance.
 In Gruppo CAP stiamo lavorando per fare in modo che la doppia materialità non sia soltanto uno strumento di compliance da utilizzare in occasione della rendicontazione annuale, ma diventi un processo continuo. L’obiettivo è quello di farne il perno della nostra pianificazione industriale, della programmazione economica e delle strategie di sostenibilità. Un elemento costitutivo del nostro modo di fare impresa, in grado di orientare con coerenza le scelte gestionali e di rafforzare il nostro impegno verso un modello di sviluppo sostenibile e resiliente».
In Gruppo CAP stiamo lavorando per fare in modo che la doppia materialità non sia soltanto uno strumento di compliance da utilizzare in occasione della rendicontazione annuale, ma diventi un processo continuo. L’obiettivo è quello di farne il perno della nostra pianificazione industriale, della programmazione economica e delle strategie di sostenibilità. Un elemento costitutivo del nostro modo di fare impresa, in grado di orientare con coerenza le scelte gestionali e di rafforzare il nostro impegno verso un modello di sviluppo sostenibile e resiliente».
Dottor Colle, come vede il futuro del cammino verso lo sviluppo sostenibile? Quali sono le principali opportunità e criticità cui ci troveremo di fronte nei prossimi anni?
«Siamo in un momento storico in cui si sta manifestando una reazione di rigetto da parte di alcuni segmenti della società nei confronti di tematiche legate alla sostenibilità e alla diversity, così come verso alcune richieste in termini di compliance. Un esempio significativo è rappresentato dalle resistenze che, a livello europeo, si sono concretizzate nel cosiddetto decreto Omnibus, che ha messo in discussione alcuni aspetti della CSRD.
Analogamente, il settore dell’automotive sta vivendo un ripensamento rispetto alle politiche di elettrificazione che erano state finora promosse con convinzione. E uno sguardo agli Stati Uniti conferma questa tendenza: anche su temi come la Diversity & Inclusion si registrano segnali di arretramento, che contrastano con i progressi compiuti negli ultimi anni. In questo scenario, la prima domanda che dobbiamo porci è: cosa non ha funzionato? Se oggi ci troviamo di fronte a una società civile, un mondo produttivo e istituzioni che sembrano fare passi indietro rispetto a temi considerati centrali, è necessario riflettere sulle cause. Forse l’eccesso di comunicazione, l’iper-narrazione della sostenibilità, oppure una compliance percepita come troppo rigida. O forse ancora, non si è dato peso a sufficienza ai costi reali, economici e sociali, della transizione energetica ed ecologica. Chi si occupa di sostenibilità ha quindi il dovere di interrogarsi su ciò che è andato storto, ma al tempo stesso ha il compito di rilanciare, con determinazione. Le sfide che ci attendono, infatti, non si superano senza azioni concrete, intenzionali e strutturate.

La Centrale di Trezzo sull’Adda (Mi).
Se ne è parlato recentemente anche in occasione del convegno di lancio dell’Oscar di Bilancio, uno dei premi più autorevoli nel panorama italiano, organizzato da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi per valorizzare i migliori report di sostenibilità. In quel contesto si è ragionato su come questo passaggio storico possa rappresentare una sorta di spartiacque: un’opportunità per distinguere chiaramente chi ha fatto della sostenibilità una leva autentica di strategia e modello di business, da chi invece ne ha fatto un semplice strumento di comunicazione o, peggio, di greenwashing. Insomma, siamo in un momento storico complesso per chi fa sostenibilità, ma anche strategico, in cui chi crede davvero nell’importanza dell’integrazione degli aspetti ESG nel business potrà dare prova di trasparenza e autenticità».
(19 luglio 2025)